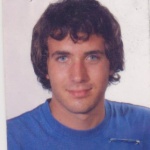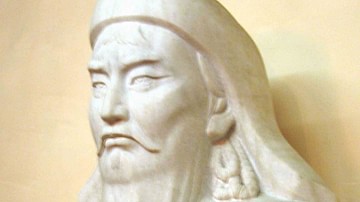I Mongoli conquistarono gran parte dell'Asia tra il XIII e il XIV secolo grazie alla velocità della loro cavalleria leggera e ai loro eccellenti arcieri. Un altro importante contributo alle loro imprese fu l'adozione di tattiche e tecnologie nemiche, che gli permise di sconfiggere potenze militari affermate come Cina, Persia e diversi stati dell'Europa orientale. Adattandosi a differenti sfide e contesti, i Mongoli diventarono abili sia negli assedi che nella guerra navale, due ambiti molto distanti dalle loro origini nomadi nella steppa asiatica. Inoltre, per vincere le battaglie addirittura prima che avessero luogo, impiegarono in egual misura diplomazia, spionaggio e metodi per infondere terrore ai loro avversari. Alla fine, riuscirono a fondare l'impero più esteso che il mondo avesse mai visto, e la loro crudeltà in combattimento gettò un'ombra di paura sulle popolazioni conquistate. I loro generali si guadagnarono soprannomi spaventosi come "segugi della guerra" e i loro soldati furono etichettati come i "cavalieri del demonio".
Uno Stato votato alla guerra
Una delle principali fonti di legittimazione per un capo tribale mongolo era la sua abilità militare e la capacità di ottenere bottino per i suoi seguaci. Sotto il comando di Genghis Khan, in carica dal 1206 al 1227 e fondatore dell'Impero mongolo (1206-1368), le sue genti si riorganizzarono con il preciso scopo di creare un apparato in grado di sostenere una guerra perpetua. Vennero create 98 unità tribali (il cui numero successivamente aumentò), le cosiddette minghan o "migliaia", ciascuna delle quali doveva fornire all'esercito 1.000 coscritti. Il khan aveva anche la sua guardia personale, la kesikten, formata da 10.000 soldati, che costituivano le truppe scelte dell'esercito permanente mongolo e che addestravano i comandanti delle altre divisioni. Una terza fonte di soldati erano i contingenti forniti dagli alleati e dai popoli conquistati, che nelle campagne in Cina e in Persia erano addirittura più numerosi degli stessi Mongoli. Successivamente, quando Kublai Khan (in carica dal 1260 al 1294) fondò la dinastia Yuan in Cina (1271-1368), gli eserciti mongoli erano composti interamente da soldati professionisti.
I loro capi si assicuravano la lealtà e aumentavano le loro possibilità di successo promuovendo i comandanti in base al merito e non per anzianità nel clan, come veniva fatto prima di Genghis Khan. La motivazione era alta perché il bottino veniva diviso equamente; c'era persino un organo dedicato alla spartizione, il jarqu, che si assicurava che le divisioni fossero corrette. I premi più ambiti erano cavalli, schiavi, metalli preziosi, tessuti, beni di lusso e persino cibo. I comandanti potevano ricevere, oltre al bottino, anche terre o tributi dai popoli conquistati. Ai soldati veniva data una ricompensa come risarcimento per la coscrizione, a cui erano soggetti tutti i mongoli maschi dai 14 ai 60 anni.

Genghis Khan, oltre a essere generoso con le ricompense, esigeva disciplina e qualsiasi soldato o comandante che disobbediva agli ordini veniva severamente punito, generalmente con la fustigazione. Un soldato non doveva aspettarsi niente meno che la pena di morte in caso di diserzione, ritirata senza ordini o per essersi addormentato mentre era di sentinella. Ciononostante, il khan dava ai suoi subordinati grande autonomia sul campo di battaglia, e questa flessibilità di solito dava risultati.
La pianificazione e la logistica erano prese attentamente in considerazione, come si può vedere al meglio nelle complesse campagne nella Russia meridionale e in Europa orientale dal 1237 al 1242, quando molti eserciti mongoli ingaggiarono singolarmente i loro obiettivi per poi riunirsi in tempi e luoghi prestabiliti. Un aiuto significativo nel localizzare alleati e nemici in qualsiasi momento era fornito dall'eccellente servizio di messaggeri mongoli, lo yam, che si serviva di una serie di stazioni di posta dotate di rifornimenti e cavalli freschi. Per comunicare tra due divisioni lontane venivano usati anche i segnali di fumo. Un altro punto di forza, come già accennato, era la politica di reclutare i non-mongoli. Gli uiguri vennero arruolati in gran numero, così come curdi e khitan, mentre coreani e cinesi costituirono una parte significativa delle forze che invasero il Giappone nel 1274 e nel 1281. In breve, dunque, i Mongoli erano costantemente pronti alla guerra.
Addestramento e armi
I guerrieri venivano formati fin dall'infanzia grazie alla tradizione mongola di far partecipare giovani maschi e femmine a gare di atletica, corse di cavalli, lotta libera, caccia e tiro con l'arco. I combattenti - principalmente uomini ma a volte anche donne - erano dunque già esperti nell'uso di asce da battaglia, lance (spesso dotate di uncino per far cadere gli avversari da cavallo), pugnali, coltelli lunghi e spade tipicamente corte, leggere e affilate solo da un lato.
L'arma prediletta dei Mongoli era l'arco composito, con cui riuscivano a tirare le frecce al doppio della distanza degli eserciti avversari. Inoltre, i soldati potevano scagliare le loro frecce con accuratezza mentre cavalcavano grazie alle staffe e a selle di legno dotate di anteriore e posteriore alti che gli davano una stabilità migliore per tirare con l'arco in ogni direzione, compreso all'indietro. L'arco composito era formato da diversi strati di legno, bambù o corno, che lo rendevano forte e flessibile allo stesso tempo. Essendo incordato contro la sua curvatura naturale, era richiesta una certa forza per tenderlo, ma poi le frecce venivano scagliate con un'accuratezza e una capacità di penetrazione superiori.
Le punte delle frecce di solito erano fatte di osso e, più raramente, di metallo; l'asta era in legno o giunco, o una combinazione di entrambi; per l'impennaggio si usavano piume di uccelli. Le frecce variavano in base allo scopo per cui erano pensate - potevano essere usate per ferire da distanza ravvicinata, per colpire obiettivi distanti, penetrare un'armatura, per avvelenare o, addirittura, per fare da segnale con il loro sibilo alle altre unità. Un tipico arciere a cavallo portava due o tre archi e nella faretra aveva circa 30 frecce leggere e 30 pesanti. L'equipaggiamento in dotazione comprendeva un lazo di crine di cavallo, un rotolo di corda, un'ascia, una lima per creare punte per le frecce, materiale per fare cuciture di riparazione, una borsa di cuoio per il cibo usata anche come galleggiante per guadare i fiumi, due borracce di cuio per i liquidi e un tegame per cucinare. I soldati dormivano in gruppi da dieci in versioni più piccole della yurta, la classica tenda mongola.
Per i Mongoli i cavalli erano essenziali perché fungevano da mezzo di trasporto, fonte di ricchezza e mezzo per misurarla, cibo e, per finire, di mobilità in guerra. Si trattava di bestie relativamente piccole ma robuste, con un manto folto e capaci di sopportare le avversità. Avevano un'eccellente resistenza, che permetteva ai cavalieri di coprire tra i 95 e i 120 chilometri al giorno, una distanza impressionante. I Mongoli disponevano sia di cavalleria leggera che pesante, e ogni cavaliere aveva normalmente fino a 16 destrieri di ricambio, che gli consentivano di avere un lungo raggio di manovra. Sul campo di battaglia, le unità di cavalleria rispondevano a ordini comunicati con gong e tamburi anche se, curiosamente, il primo attacco veniva sempre condotto in silenzio. I cavalli potevano anche essere usati come fonte di nutrimento durante una campagna: in caso di necessità, veniva praticato un foro sul collo per bere il sangue. Le razioni normali prevedevano formaggio essiccato e carne salata.
Armatura
Le armature erano leggere per non diminuire la velocità dei cavalieri, ed erano fatte tipicamente di uno spesso strato di feltro o cuoio. A volte venivano rafforzate aggiungendo listarelle di metallo, osso o cuio indurito, ma le armature a piastre o le cotte di maglia erano rare, anche se alcuni le indossavano dopo averle sottratte ai nemici. Appresero dai cinesi l'utilizzo di una maglietta di seta, che aveva la pratica utilità di arrotolarsi intorno alle punte delle frecce, proteggendo chi la indossava e facilitando l'estrazione della freccia.
La testa veniva protetta con un elmetto di ferro o cuoio indurito, dotato qualche volta di una guardia per il collo e ornato con una punta centrale o delle piume. Un'alternativa era la tradizionale pelliccia mongola con le alette laterali e gli orli rovesciati. Gli scudi, quando venivano usati, erano portati tipicamente dalla fanteria ed erano piccoli, circolari e fatti in vimini o cuio temprato. Qualche volta anche ai cavalli veniva fatta indossare un'armatura fatta con gli stessi materiali già menzionati. Per la testa del cavallo veniva usata un'armatura a piastre ma, per il resto, si usavano armature imbottite.
Tattiche
Pianificazione
Una delle ragioni principali del successo dei Mongoli era la preparazione prima dello scontro con il nemico. Le loro spie erano mercanti viaggiatori, preti o disertori, e raccoglievano informazioni sulle capacità e le debolezze del nemico, sull'eventuale presenza di dissidenti e persino sulla possibilità di allearsi con gli avversari dei loro nemici. Prima di una grande campagna aveva luogo un grande incontro dell'aristocrazia mongola, il kuriltai, nel quale si discutevano in dettaglio piani e strategie. Una volta sul campo, gli esploratori continuavano a raccogliere informazioni a circa 110 chilometri oltre il fronte, oltre che su entrambi i lati delle colonne mongole disperse per assicurarsi di non essere presi alla sprovvista o di cadere in un'imboscata.
Manovre
Gli eserciti mongoli si muovevano con estrema rapidità e cercavano di superare in astuzia i nemici con velocità e coordinazione. Lo scopo era di ingaggiare il nemico solo quando era assolutamente necessario, e si impegnavano grandi forze solo quando era stata individuata una specifica debolezza. Questa strategia aveva lo scopo ottenere il massimo risultato con il minimo delle perdite. Le unità di cavalleria, le minghan da circa 1.000 uomini, erano suddivise in unità da cento soldati, le jagun, che a loro volta si dividevano nelle arban, unità da dieci cavalieri.
Un esercito mongolo sul campo si divideva in due ali operanti di fianco a un centro e un'avanguardia. Persino il loro accampamento seguiva questa suddivisione. La cavalleria raramente superava le 10.000 unità in un determinato posto nello stesso momento; persino nelle loro campagne più grandi, come quelle in Europa, non erano presenti più di tre di queste formazioni da 10000 cavalieri, le cosiddette tumen. Il resto del loro esercito, forse di numero triplo rispetto alle dimensioni della cavalleria, era formato da alleati che facevano la guerra secondo le loro tradizioni. I Mongoli erano generalmente in condizione di inferiorità numerica sul campo di battaglia rispetto ai loro avversari, ma riuscivano a superare questo svantaggio grazie a una maggiore velocità e all'utilizzo di tattiche superiori. Uno svantaggio nell'avere un esercito relativamente piccolo era quello di rimpiazzare le perdite. Spesso venivano arruolate truppe sconfitte, ma in campagne come quella in Europa orientale, dove la lealtà presente tra i loro avversari era più forte, a volte era necessario ritirarsi e aspettare rinforzi che dovevano arrivare dalla Mongolia.

Una loro strategia classica era di attaccare con un piccolo drappello che poi fingeva di ritirarsi; gli inseguitori però si trovavano davanti a una forza più numerosa. Altra manovra tipica era la tulughma, che consisteva nell'attaccare lo schieramento nemico al centro con un gruppo di cavalleria pesante nelle prime linee e di cavalleria leggera a rimorchio, che aveva il compito di muoversi tra i varchi; mentre i cavalieri facevano il loro movimento, altre unità a cavallo si muovevano sui lati per circondare il nemico. Questa era una versione in scala ridotta della nerge, cioè la tattica che i Mongoli usavano per cacciare su vaste aree della steppa e con la quale mettevano all'angolo la selvaggina. Alcune volte le ali del loro schieramento erano così estese che gli permettevano di circondare l'intero esercito nemico. Una riserva di cavalleria pesante si occupava di finire gli avversari e inseguire quelli che scappavano, a cui veniva data la caccia anche per giorni dopo la battaglia.
Un'altra tattica comune era l'imboscata, che veniva effettuata con la copertura del fumo di erba data alle fiamme o di nuvole di polvere create per mascherare i movimenti delle truppe o attaccando nel momento meno atteso, come durante una tempesta. I Mongoli impiegavano anche alcune strategie inusuali per ingannare i loro nemici. Per esempio, a volte si servivano di fantocci in pelle animale che montavano a cavallo in mezzo alle unità di cavalleria, per far credere al nemico che il loro numero fosse maggiore. Un'altra strategia innovativa fu il lancio di volantini con gli aquiloni sulla città assediata di Kaifeng nel 1232, con i quali si incoraggiava la popolazione ad arrendersi in cambio di una ricompensa.
Terrore
Una delle strategie che ebbe più successo fu il terrore. Per esempio, quando veniva presa una città, l'intera popolazione civile poteva essere giustiziata - uomini, donne, bambini, preti, persino cani e gatti - e venivano lasciati in vita pochi sopravvissuti a cui veniva permesso di scappare per raccontare le atrocità subite alle città vicine. Di conseguenza molte città, quando sentivano che i Mongoli erano in avvicinamento, si arrendevano senza combattere nella speranza di avere clemenza, che spesso veniva concessa. Una strategia persino più sottile fu usata nel conflitto contro la dinastia Jin nel nord della Cina, nel corso del primo decennio del XIII secolo, quando i Mongoli saccheggiarono ripetutamente le città, a volte sempre la stessa, per poi lasciare che i Jin le riprendessero, essendo poi obbligati a gestire il caos che era stato creato.
Un'altra strategia crudele era quella di usare i prigionieri come scudi umani quando avanzavano verso città fortificate, miopi abbastanza da opporre resistenza; i prigionieri venivano persino vestiti da guerrieri mongoli e fatti marciare nelle prime file, affinché i difensori sprecassero le loro preziose frecce uccidendo i loro stessi compatrioti. Un'altra fonte di terrore era costituita dal trattamento che riservavano ai morti; i corpi venivano mutilati e i soldati spesso prendevano trofei dai caduti, di solito le loro orecchie.
In sintesi, dunque, i Mongoli erano inarrestabili sui campi di battaglia per tutte le ragioni esposte finora, come notato dallo storico S. R. Turnbull:
Il modo di fare la guerra dei Mongoli era una combinazione quasi perfetta di potenza, tattiche d'urto e mobilità. Le manovre stesse, frutto di esperienza, addestramento e disciplina, erano eseguite alla perfezione... Loro stessi si credevano invincibili, un'idea condivisa anche dalla maggior parte dei loro avversari sconfitti, che li consideravano un castigo divino per la punizione dei loro peccati. (27-8)
Assedi e guerra navale
I Mongoli avevano un altro asso nella manica, cioè l'abilità di adattarsi a nuovi modi di combattere. Per esempio, la capacità di assediare le città divenne necessaria quando incontrarono nemici come i Song cinesi, i persiani e i regni dell'Europa orientale. All'inizio le mura delle città ben fortificate misero alla prova la loro risolutezza, ma impararono presto dai loro nemici e dai consiglieri locali a usare la polvere da sparo e armi come piccoli cannoni portatili, scagliando ordigni contenenti fuoco greco, gas sulfureo o schegge contro le mura dei centri abitati. Avevano anche dei razzi, balestre a tre frecce e grandi catapulte messe in moto mediante torsione, sistemi di contrappesi o da uomini che azionavano un sistema di corde. Alcune catapulte erano mobili mentre altre erano montate sulle navi.

Alcuni assedi potevano durare anni nonostante i bombardamenti, come quella della città Song fortificata di Xiangyang, che venne presa con l'uso di arieti e catapulte progettate da ingegneri islamici. Questi eserciti statici richiedevano anche uno sforzo logistico molto più grande rispetto alle tradizionali unità di cavalleria, le quali dovevano sostentarsi come meglio potevano finché non venivano rifornite dai convogli di carri, bestie da soma o cammelli, che spesso erano gestiti dalle donne mongole. Un'altra sfida fu quella di imparare la guerra navale. Negli anni Settanta del Duecento, dopo la sconfitta dei Song, i Mongoli ebbero la loro flotta, composta da 5.000 navi e 70.000 marinai, utilizzabile sia sui fiumi che in mare. Al comando di coreani e cinesi, delle imponenti flotte invasero il Giappone e il Sud-est asiatico, ma queste grandi navi, che in origine erano vascelli mercantili, erano state pensate per il trasporto di truppe e non come navi da guerra. Come sempre, il compito di ottenere la vittoria una volta sbarcati spettava alla cavalleria.
Il declino
I Mongoli possono aver creato un impero che andava dal Mar Nero alla penisola coreana, ma non furono sempre vittoriosi nelle loro campagne. Alcune città si rivelarono troppo difficili da prendere e la logistica divenne un problema crescente con l'allontanarsi delle operazioni militari dalla loro roccaforte in Mongolia. Le due invasioni del Giappone furono frustrate dalla combinazione di una dura resistenza e di tempeste che colpirono il loro esercito. Le campagne nel Sud-est asiatico ottennero dei successi ma i risultati furono altalenanti: i Mongoli faticavano a convivere con la giungla tropicale, le pesanti piogge, le malattie e armi a cui non erano abituati, come le frecce avvelenate sparate dalle cerbottane, elefanti da guerra e un'efficace guerriglia condotta dal nemico. Persino in Cina dovettero ritirarsi al cospetto della nuova grande potenza dell'Asia orientale: la dinastia Ming. Nel 1368 i Mongoli si erano indeboliti a causa di una serie di siccità, carestie e dispute dinastiche all'interno della loro aristocrazia. Si può affermare che i Mongoli, che in origine erano un popolo nomade, furono davvero sconfitti solo da sé stessi perché erano diventati parte delle società sedentarie che avevano combattuto per così tanto tempo.